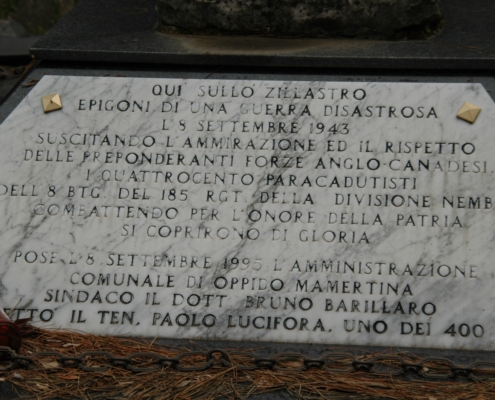“Come a contatto dell’aria le antiche mummie si polverizzano, si polverizzò così questa vita. È una civiltà che scompare, e su di essa non c’è da piangere, ma bisogna trarre, chi ci è nato, il maggior numero di memorie». La frase di Corrado Alvaro descrive bene gli ultimi abitanti di Roghudi.
All’inizio degli anni ’90 cominciai a guidare gruppi di escursionisti in Aspromonte e Roghudi era una delle nostre tappe. Il paesino, in bilico sulla fiumara Amendolea, era stato dichiarato inagibile dal 1972 e quindi senza luce, acqua, ecc. Don Rafele (Raffaele Favasuli) era uno dei tre abitanti che non era voluto andare via.
Giungevamo supportati da un paio di furgoni carichi di viveri e attrezzatura da campeggio per 40 persone ma, nonostante questo dispiego di mezzi e la nostra preponderanza numerica, era lui il re di Roghudi. Dormivamo nella chiesa ormai sconsacrata che, anche se cadente, era l’unico edificio in grado di offrire un tetto a tante persone. Era lui, don Rafele detto Ciciuni, che mi consegnava le chiavi, dopo numerose raccomandazioni sul comportamento da tenere nell’edificio, per lui ancora sacro, ed in particolare per l’abbigliamento delle donne. Cercavamo di ricambiare la cortesia offrendo dolci e altro ma lui ci sopravanzava sempre. Entrava in una casa abbandonata e ne usciva fuori con un paniere colmo di ciliegie, da un’altra portava una cassa di birre fresche, da un balcone un cesto di fichi. Per non parlare delle cene consumate nell’unica minuscola piazza del paese (in 40 ci stavamo stretti) dove, appena la pasta era servita a tavola, passava con la ricotta salata grattugiandola così fitta e in una striscia ininterrotta sui piatti, sulle mani, sulla tavola che sembrava nevicasse. E a conclusione l’immancabile tarantella gestita da Nino Pangallo detto Palitta che nonostante gli anni teneva testa a tutti nel ballo.
Era una gioia per loro vedere rivivere il paese, anche se solo per una notte. Ma la gioia più grande è stata la mia che ho potuto intravedere gli ultimi bagliori di una civiltà che stava scomparendo.
Alcune foto d’epoca sono di Enzo Acri del CAI Edelweiss di Milano, tra i primi a portare gruppi di escursionisti in Aspromonte ed ancora oggi sulla breccia.
Approfondimenti in https://www.laltroaspromonte.it/3d-flip-book/guida-naturalistica-della-calabria-greca
https://www.laltroaspromonte.it/3d-flip-book/nei-paesi-delle-minoranze-linguistiche
e in altri volumi e articoli disponibili sul sito.